|
Lunedì 22 settembre 2014 gli operatori della
Società Meteorologica Italiana hanno eseguito le consuete misure di
bilancio di massa e variazione frontale al Ghiacciaio Ciardoney (Gran Paradiso).
Come sempre
IREN Energia ha contribuito in modo fondamentale alla
logistica della missione, mettendo a disposizione il trasporto su
piano inclinato in galleria dalla diga di Telessio (1917 m) a quella
di Valsoera (2400 m) per abbreviare l'altrimenti lunghissimo
avvicinamento al Colle Ciardoney e al ghiacciaio.
Non essendo disponibile l'elicottero si è infatti scelto di salire
ugualmente, ma a piedi, approfittando di una delle rare giornate
serene e limpide di questo periodo, in modo da portare a termine le
misure basilari in considerazione della data ormai tardiva rispetto
alla media dei precedenti controlli (5-15 settembre) a causa dei
numerosi rinvii dovuti proprio al frequente maltempo di questa
stagione.
Ulteriori operazioni (posa di nuove paline ablatometriche,
manutenzione stazione meteorologica...) verranno possibilmente
eseguite con una prossima missione autunnale.

Una veduta generale del ghiacciaio Ciardoney dalla stazione
fotografica «F».
Il 22 settembre 2014 il ghiacciaio appariva coperto di neve stagionale
residua solo più oltre i 3050 m circa (un po' più in basso solo
all'ombra del versante settentrionale delle Uje di Ciardoney) tanto
che, nuovamente, il bilancio di massa è risultato negativo (-0,58 m di
acqua equivalente).
Nonostante l'abbondante
innevamento invernale e primaverile e l'estate
nuvolosa e relativamente fresca, i tepori di settembre (finora
circa 1 °C sopra media in Piemonte) sono riusciti a estendere la
completa fusione della neve stagionale ad almeno due terzi del
ghiacciaio, sotto i 3050 m circa, determinando così una situazione
moderatamente negativa, con bilancio di massa pari a -0,58 m
di acqua equivalente, pressoché identico a quello della
stagione 2012-13 e in perfetto accordo con il valore di -0,57 m
rilevato il giorno precedente dall'équipe del Parco Nazionale Gran
Paradiso al ghiacciaio valdostano del Grand Etret, 15
chilometri a Ovest e ad altitudini analoghe.
Stazionaria invece la posizione della fronte, in parte ancora
nascosta sotto locali accumuli di neve residua presso entrambi i
segnali di misura.
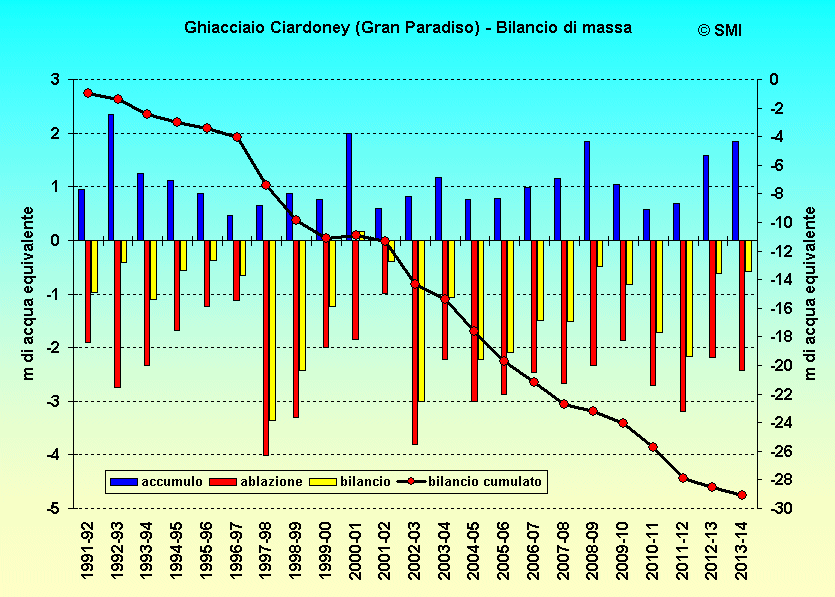
Serie dei bilanci
di massa annuali (accumulo, ablazione, bilancio netto) e cumulati
dalla stagione idrologica 1991-92, espressi in metri di equivalente
d’acqua.
La stagione 2013-14 ha visto perdite di spessore glaciale
nulle alla palina n. 1 (Colle Ciardoney) e poi crescenti più a valle
fino ai 180 cm
della palina n. 7 (settore frontale), corrispondenti a una lama
d’acqua media di 0,58 m.
Dunque ancora un bilancio negativo (sebbene meno drastico rispetto
alla media di
-1,3 m del periodo 1992-2013), nonostante l'importante innevamento dell'inverno
2013-14 e l'estate nuvolosa e moderatamente fresca.
Il valore cumulato del bilancio in 23 anni è ormai giunto a ben -29 m.
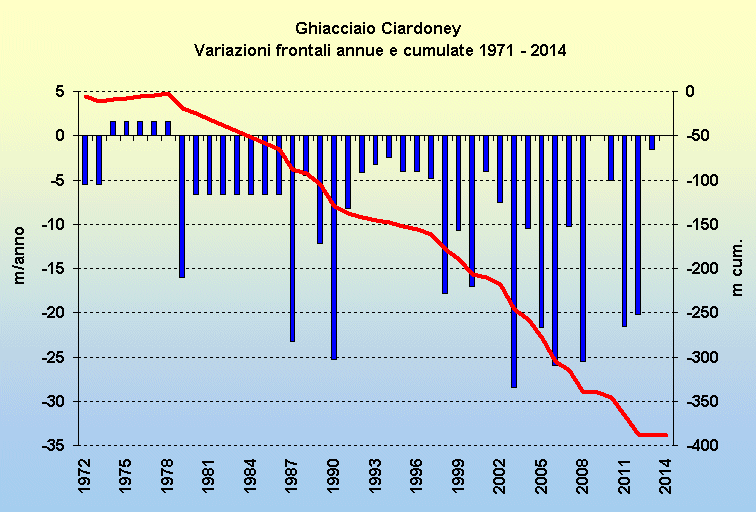
Serie delle
variazioni frontali e cumulate dal 1971 al 2014 al Ghiacciaio
Ciardoney.
Quest'anno la posizione esatta della fronte, verosimilmente
stazionaria, è nascosta da locali accumuli di neve residua presso
entrambi i segnali di misura A5C e A4D.
Tuttavia la situazione del ghiacciaio nel suo insieme appare ancora
una volta sfavorevole, seppure in maniera più moderata rispetto a
molte stagioni recenti.
Il regresso frontale totale
dall'inizio dei rilievi nel 1971 è giunto a ben 388 m.

In prossimità dei
due segnali di misura frontali (A5C e A4D) la posizione del margine
glaciale, benché nascosta da accumuli localizzati di nevato, si può
considerare ragionevolmente stazionaria.


L'intensità del
regresso glaciale avvenuto da metà Anni 1980 si coglie ancor più
efficacemente dal confronto fotografico tra il 5 settembre 1986 (f. L.
Mercalli), quando era da poco terminata la breve fase di stasi o lieve
progresso cominciata a inizio Anni 1970, e il 22 settembre 2014
(f. D. Cat Berro). In questi 28 anni la fronte si è ritirata di circa
325 m.
Ecco un foto-racconto della giornata di
misure, favorita da atmosfera limpida, fresca e asciutta dopo
il passaggio del fronte freddo da Nord-Ovest della sera precedente,
che ha attivato venti di föhn moderati - tesi nelle valli sudalpine.

Il nuovo «carrello» per il trasporto del personale di servizio IREN in
galleria tra le dighe di Telessio e Valsoera, di cui anche SMI - come
già molte altre volte a partire dal 1986 - ha beneficiato per
abbreviare il tragitto a piedi verso il ghiacciaio Ciardoney.

La marcia verso il
Colle Ciardoney dal versante della Valle Orco (circa 3 ore di salita,
700 m di dislivello dapprima su rocce montonate e pascoli, poi
pietraie e morene)
inizia dunque alla diga IREN di Valsoera (2400 m). Nell'immagine, il
Colle Ciardoney si trova a destra, appena nascosto dietro la cresta a
fil di cielo alla testata del vallone.

Si attraversano i
bei piani alluvionali dell'Alpe di Valsoera, prima di iniziare
la ripida e faticosa salita del colatoio detritico (a destra)
verso le morene dei ghiacciai di Valsoera.

Luca Mercalli
risale l'esile traccia verso le morene dei ghiacciai di Valsoera.

Giunti a mezz'ora
di marcia dal Colle Ciardoney, ecco apparire i due minuscoli ghiacciai
di Valsoera (il meridionale a sinistra, e il settentrionale a destra),
entrambi ancora interamente coperti di neve residua.

Il ghiacciaio
Settentrionale di Valsoera, nascosto sotto l'abbondante nevato
derivante dalle grandi valanghe convogliate dai soprastanti canaloni
nelle ultime due stagioni, 2012-13 e 2013-14.

Il laghetto
glaciale al margine del ghiacciaio Settentrionale di Valsoera e appena
sotto il Colle Ciardoney. Si è formato nel corso degli Anni 2000 a
seguito della scomparsa della trasfluenza del ghiacciaio Ciardoney sul
versante Orco. Quella che circonda lo specchio d'acqua è neve residua
delle stagioni 2013 e 2014, non ghiaccio vero e proprio.

Ed ecco il Colle
Ciardoney (3100 m), spartiacque tra Valle Orco e Val Soana. Subito
dietro si estende il ghiacciaio Ciardoney, raggiungibile in pochi
minuti.

Il ghiacciaio
Ciardoney, dal colle omonimo. Qui ha resistito uno strato di 75 cm
di neve stagionale (dei 380 cm presenti il
9 giugno 2014), che si sovrappone ai 70 cm rimasti dall'estate
2013. Tuttavia, poche decine di metri più a valle, in prossimità
della palina ablatometrica n. 2, già il nevato scompariva e iniziava a
emergere il ghiaccio sottostante.

La palina n. 2 si
trovava proprio in prossimità della linea di equilibrio del ghiacciaio
che separa la zona di accumulo (ancora coperta di neve residua, a
monte) e quella di ablazione (ghiaccio affiorante e in fusione, a
valle). In questo punto il ghiaccio ha appena cominciato a scoprirsi,
e l'ablazione nell'estate 2014 è stata nulla, tuttavia è stato
possibile rilevare una perdita di spessore di 23 cm attribuibile
all'inizio autunno 2013, avvenuta tra il 13 settembre (precedente
misura) e il 10 ottobre 2013 (prima nevicata importante dell'inverno 2013-14).

Il settore
superiore del ghiacciaio, con una ristretta fascia di neve residua
solo oltre i 3050 m circa.

Un «cono»
generatosi dalla protezione del ghiaccio dalla fusione da parte di un
accumulo localizzato di detrito, trasportato e concentrato lì dalle
acque superficiali.

I «mulini
glaciali», sul settore mediano del ghiacciaio, erano quasi
completamente ostruiti da un «coperchio» di neve residua, situazione
che li rende difficilmente individuabili (se non per il rombo delle
acque di fusione che vi si inabissano) e dunque molto pericolosi.

La palina
ablatometrica n. 3: qui si è rilevata una perdita di spessore glaciale
di 105 cm
dalla
precedente misura del 13 settembre 2013.

Una marcata «bédière»
incisa dalle acque di fusione poco a monte della fronte, ma
probabilmente impostatasi lungo una frattura del ghiaccio già
esistente in questa zona in cui la coltre glaciale è ormai ridotta a
pochi metri di spessore e in via di frammentazione.

Atmosfera di metà
pomeriggio in riva a uno dei tre laghetti proglaciali.

Rocce montonate
abbandonate dal ghiacciaio da oltre mezzo secolo e disseminate di
massi erratici. Sullo sfondo, la possente mole rocciosa del Monte
Gialin (3270 m).

La stazione
meteorologica automatica, sempre in ottime condizioni nonostante il
difficile ambiente d'alta quota, e l'asta nivometrica sorvegliata
tramite webcam.

Con temperatura
dell'aria di circa 6 °C e intensa radiazione solare, la fusione
procedeva nelle ore pomeridiane, arrestata solo temporaneamente dal
rigelo notturno.

Daniele Cat Berro riflette sui dati appena raccolti alle paline
ablatometiche.

Sulla via del
rientro a Valsoera... veduta dal Colle Ciardoney verso la bassa Valle
Orco e la pianura torinese. Veli di cirrostrati, ottima visibilità e
pochi cumuli sulle Prealpi, come in queste zone, frequentemente
nebbiose, si può vedere solo con il vento da Nord-Ovest.

Con le ultime luci del tramonto e sotto forti raffiche di vento
settentrionale, giungiamo alla diga di Valsoera, appena in tempo prima
della notte. Sui cirrostrati rosati dal sole calante si stagliano i
vertiginosi gendarmi della poco distante Punta di Fioni (2384 m).

Ultimo tratto a
piedi in galleria, a fianco della condotta forzata che convoglia
l'acqua dell'invaso di Valsoera alla centrale idroelettrica in caverna
presso la diga di Telessio.
I guardiani IREN ci attendono per il trasporto a valle:
usciremo dalla galleria a notte fatta, ma con le misure in tasca!
Segui in in tempo reale la situazione sul Ghiacciaio Ciardoney (dati
meteo e webcam)
Devolvi il 5 per mille alla SMI, sosterrai le ricerche sul Ghiacciaio
Ciardoney!

Un particolare ringraziamento a
Valtecne
per il supporto alle campagne di misura sul Ciardoney

|