|
Mercoledì 6
settembre
2017 la Società
Meteorologica Italiana ha eseguito le misure di bilancio di massa e
variazioni frontali al Ghiacciaio Ciardoney (Gran Paradiso), grazie
all'appoggio logistico e operativo di
IREN Energia
e dell’Ente Parco Nazionale
del Gran Paradiso, nell'ambito delle regolari campagne di
osservazione sulle Alpi promosse dal
Comitato
Glaciologico Italiano.
I calori estivi
intensi e prolungati (seconda estate più calda in oltre due secoli in
Piemonte e anche nell'insieme
d'Italia) hanno completamente privato il ghiacciaio della pur
abbondante neve dello scorso inverno (305-420 cm al 31 maggio
2017), ma la cui presenza fino
a metà estate ha per lo meno limitato un po' l'ablazione su ghiaccio
evitando una situazione che avrebbe potuto avvicinarsi a quella di
annate "disastrose" come il 1998, 1999, 2003, 2005, 2006, 2012...
Decisamente negativi,
comunque, sia il bilancio di massa (-1,39 m di acqua
equivalente nell'insieme del ghiacciaio) sia le variazioni frontali
(12,5 m di regresso).

Il settore
superiore del ghiacciaio Ciardoney visto dall'elicottero il 6
settembre 2017,
completamente spoglio di neve residua fino alle quote più elevate
(3100 m, Colle Ciardoney, sullo sfondo).
Ecco le perdite di spessore
di ghiaccio osservate alle singole paline ablatometriche rispetto al
precedente
sopralluogo del 13 settembre 2016, da monte a valle
(in parentesi le quote approssimative):
1. (Colle Ciardoney, 3100 m): -65 cm. Qui si è
completata la fusione dello strato di ghiaccio nuovo (spesso 30 cm)
che - limitatamente all'estremità superiore del ghiacciaio - si era
formato grazie alla neve sopravvissuta alle estati 2013 e 2014.
2. (3050 m): -117 cm
3. (3000 m): -210 cm
4. (3000 m): -187 cm
6. (2950 m): -239 cm
7. (2900 m): -155 cm, valore più moderato nonostante la
quota più bassa, solo grazie alla più lunga permanenza estiva del
nevato sul pendio frontale, sempre più concavo a seguito della perdita
di spessore glaciale e dunque più soggetto ad accumuli locali di neve
trasportata da vento e valanghe.
(palina n. 5 non più
presente)
Un sopralluogo intermedio condotto il 18
agosto 2017, con lettura della sporgenza delle paline ablatometriche
già affioranti, ha permesso di calcolare i tassi medi di fusione su
ghiaccio nei 19 giorni successivi, entro il 6 settembre, compresi tra
3,7 cm/giorno alla palina n. 4 (in posizione parzialmente
ombreggiata dalle Uje di Ciardoney) e 6,0 cm/giorno alla palina n.
6 (pendio inferiore).
Considerata l'interruzione della fusione nel periodo freddo del 2-3
settembre (determinante sulla media complessiva), è possibile che
nelle più calde giornate di fine agosto 2017 l'ablazione abbia ancora
asportato punte di 7-8 cm/giorno presso le paline più esposte alla
radiazione solare.

L'immagine ripresa
dalla webcam il 27 luglio 2017 mostra il ghiacciaio già "scoperto" con
il ghiaccio affiorante nel settore mediano, dove infatti le perdite di
spessore sono state maggiori per la più lunga esposizione alla
radiazione solare. Invece il settore superiore, ma anche quello in
prossimità della fronte (palina n. 7), sono ancora protetti dal nevato
stagionale, che tuttavia fonderà completamente entro il 15-20 agosto.


In corrispondenza
della palina n. 3, rappresentativa del tratto mediano del ghiacciaio,
si è perso durante l'estate 2017 uno spessore glaciale di 210 cm. Nel
settembre 2016 si camminava al livello indicato da Luca Mercalli e
Fulvio Fornengo (foto qui sopra).
Nell'immagine in alto, l'insieme dei 3 segmenti di palina fuoriusciti
(totale 6 m)
corrisponde alla fusione intervenuta in 3 anni, dal 2015 (circa 2
m/anno)!
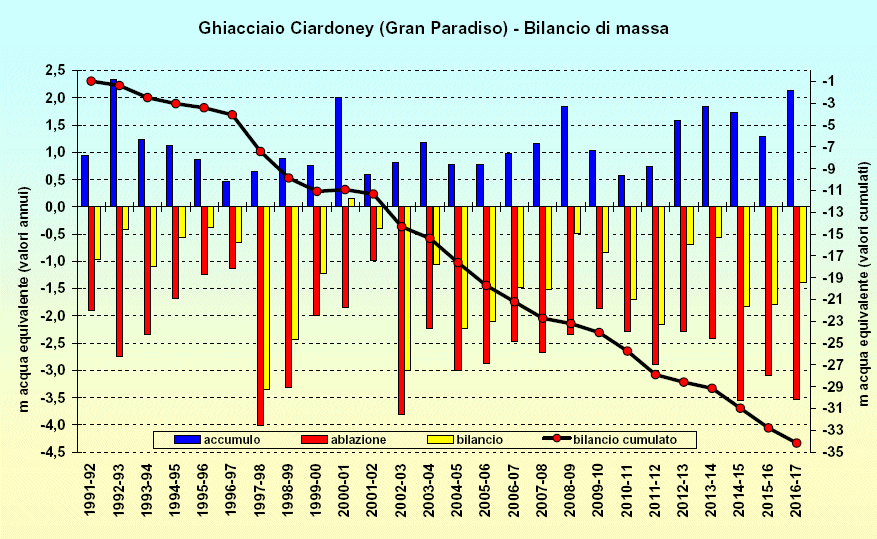
Serie delle misure
di accumulo invernale, ablazione estiva e bilancio di massa netto.
Il valore complessivo di bilancio di -1,39 m di acqua equivalente della
stagione 2016-17
si colloca vicino alla (sfavorevole) media dei 26 anni di
osservazione (-1,31 m).
Un'annata non tra le peggiori, ma che ha penalizzato ulteriormente
un ghiacciaio
già provato da una lunga serie di stagioni molto negative.
Il bilancio cumulato dal 1992 è ormai di -34,2 m.
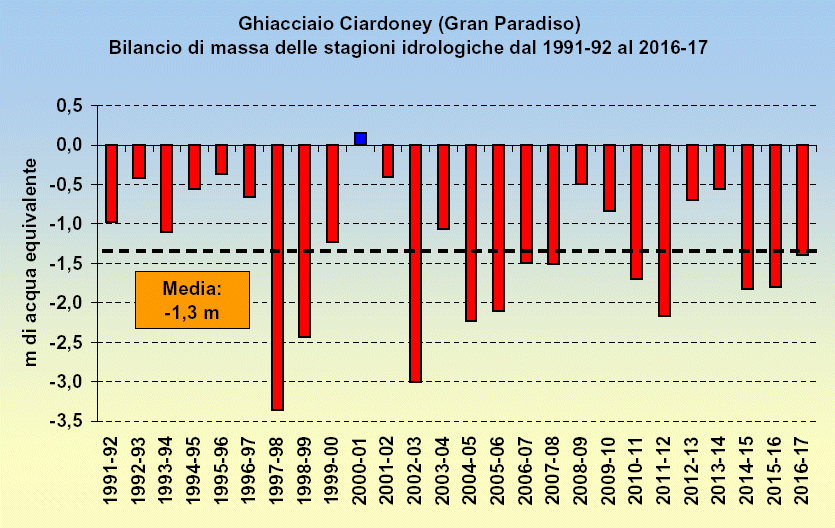
Dettaglio della
serie del bilancio di massa netto (ghiaccio perso ogni anno
nell'insieme del ghiacciaio, espresso come "lama" d'acqua media, in
m).
La media di 26 anni è pari a -1,31 m, ma nel tempo si è aggravata,
da -1,03 m nel periodo 1992-2002 a -1,52 m nel 2003-2017.




Perforazione del
ghiacciaio con sonda a vapore
(modello "Heucke", gentilmente prestato dai colleghi del
CNR-IRPI di
Torino)
per la posa di una nuova palina al sito di misura n. 2, in
sostituzione di quella collocata nell'agosto 2010 fino a 9 m di
profondità e completamente fuoriuscita proprio
a inizio settembre 2017 (media di 1,1 m di ghiaccio perso all'anno, in
questo punto a quota 3000 m circa).

6 settembre 2017,
ore 11: nonostante la copertura nuvolosa e l'ora mattutina,
l'acqua di fusione già scorre abbondante lungo le bédières nel tratto
mediano del ghiacciaio, alimentando (qui sotto) i "pozzi" glaciali,
come di consueto presenti nei pressi della palina n. 3.




Luca Mercalli
rileva la variazione frontale intervenuta in corrispondenza
del
segnale "A4D", pari a -12,5 m dal settembre 2016.
Nel suo tratto terminale, il ghiacciaio è ormai spesso meno di 10
m, diffusamente fratturato, inciso dai torrenti epiglaciali e in via
di smembramento.
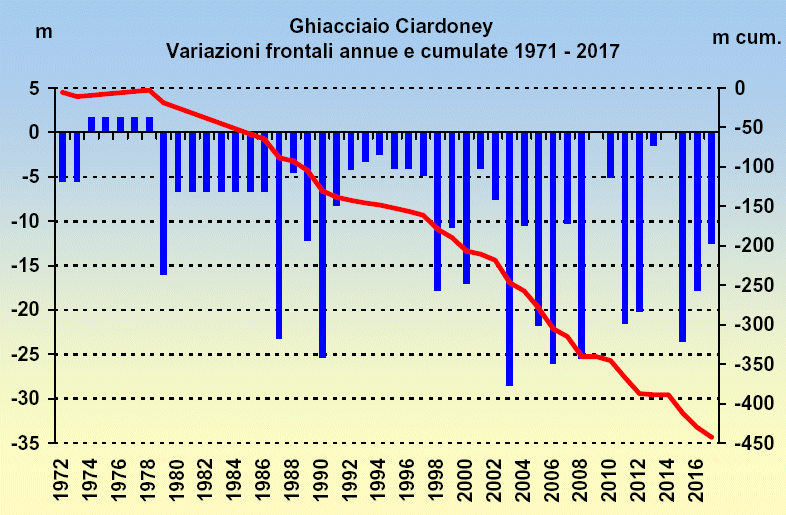
Il regresso annuo
di 12,5 m ha portato a ben 440 m circa il ritiro complessivo
dalle prime misure del 1972.

L'intenso ritiro
frontale degli ultimi anni (circa 130 m in un decennio) ha suggerito,
per maggiore rapidità e comodità delle prossime misure (settembre
2018),
l'istituzione
di un nuovo richiamo del segnale di riferimento (denominato "A4E") su
un grande masso erratico da poco deposto alla fronte, ma ormai
stabilizzato.


La stupefacente
contrazione subita dal ghiacciaio in pochi anni è evidenziata dal
confronto con l'8 settembre 2004 (stazione fotografica "F"): solo 13
anni fa il pendio frontale, benché già in forte ritiro, era ancora
visibilmente convesso, mentre oggi si presenta notevolmente smagrito e
appiattito.
La perdita di spessore è più massiccia in sinistra
orografica (destra nella foto) con rapida emersione di nuovi
affioramenti rocciosi e di substrato morenico, mentre in destra è meno
pronunciata per l'abbondante detrito franato dalla Grande Uja di
Ciardoney, che ostacola la radiazione solare proteggendo il ghiaccio
sottostante.
E' probabile, dati i modesti spessori residui, che il margine
inferiore del ghiacciaio nei prossimi 10-15 anni risalga rapidamente
il pendio deglacializzando l'area in cui oggi si trovano le paline n.
6 e 7, con probabile affioramento di un gradino roccioso presso
il cambio di pendenza del settore mediano.


Vista complessiva
del ghiacciaio Ciardoney dal punto fotografico "S2",
(oggi
a pochi metri dalla stazione meteorologica), il 5 settembre 1986, data
di inizio della sorveglianza regolare del ghiacciaio da parte di Luca
Mercalli e Fulvio Fornengo
(f. L. Mercalli) e il 6 settembre 2017. Impressionante la riduzione di
superficie, spessore
e volume glaciale intervenuta in un trentennio.

A 7 anni
dall'installazione, la stazione meteorologica "Campbell" sul pianoro proglaciale è stata equipaggiata con
nuovi pannelli fotovoltaici, inoltre sono stati riparati i tiranti di
controventatura e il traliccio stesso, danneggiati dalla pesante
coltre di neve della primavera 2017 (370 cm il 2 aprile)
e da successive raffiche di vento.

I
tecnici-elettricisti Diego Marzo e Riccardo Chiotti
durante la manutenzione della stazione meteorologica.
In tarda mattinata, pur tra banchi di cumuli e nebbia a tratti,
si misurano 7 °C (f. L. Mercalli).

Alle ore 14, il
rientro alla centrale IREN di Rosone - come spesso avviene - in
situazione marginale tra folti cumuli pomeridiani, ma in sicurezza
grazie alla perizia di pilota e assistenti di volo di
Pellissier Helicopter.

La sempre più esile
trasfluenza del ghiacciaio
a ridosso del Colle Ciardoney
sul lato Valsoera. Lo spessore del ghiaccio sulla sella lungo lo
spartiacque Orco-Soana
è ormai
certamente inferiore a 10 m, come evidenziato dal
rilievo GPR del settembre 2015, e la sua deglaciazione potrebbe
avvenire, al persistere delle condizioni attuali,
nel giro di 10-15
anni, o anche prima in caso di ulteriore (e probabile) aumento delle
temperature estive sulle Alpi.

Veduta in direzione
opposta, dal Colle Ciardoney verso il bacino dei ghiacciai di Valsoera,
con il piccolo lago formatosi e ingranditosi nel corso degli Anni
Duemila
al piede della trasfluenza glaciale.


Il piccolo
ghiacciaio settentrionale di Valsoera, a poche centinaia di metri dal
Colle Ciardoney
(al quale era collegato fino ai decenni centrali del
XX secolo),
nel volgere di 15 anni è rimasto completamente sepolto da crolli
rocciosi e frane dalla parete orientale della Punta Scatiglion (3439
m), in
evidente intensificazione come probabile effetto dello scongelamento
del permafrost sui versanti. Ghiaccio è ancora presente sotto
la coltre di detrito, ma il ghiacciaio si può ritenere pressoché
estinto.

Appena più a Sud è
ancora in parte visibile tra i detriti in aumento il minuscolo
ghiacciaio meridionale di Valsoera, ma pure esso è prossimo all'estinzione.
(*) Salvo diversa
indicazione, le immagini sono di D. Cat Berro.
Segui in in tempo reale la situazione
sul Ghiacciaio Ciardoney (dati
meteo e webcam)
Devolvi il 5 per mille alla SMI,
sosterrai le ricerche sul Ghiacciaio Ciardoney!

|