|
Venerdì 13
settembre
2019 la Società
Meteorologica Italiana ha eseguito le misure di bilancio di massa e
variazioni frontali al Ghiacciaio Ciardoney (Gran Paradiso), grazie
all'appoggio logistico e operativo di
IREN Energia
e dell’Ente Parco Nazionale
del Gran Paradiso, nell'ambito delle regolari campagne di
osservazione sulle Alpi promosse dal
Comitato
Glaciologico Italiano.

13 settembre 2019,
ore 8,30: il settore superiore del ghiacciaio, ripreso dal Colle
Ciardoney; 5 - 20 cm di neve fresca (caduti in un paio di riprese il
5-6 e 10 settembre) coprono la superficie di ghiaccio vivo ormai
spoglio di neve invernale, senza tuttavia ostacolare le misure di
bilancio di massa e variazione frontale.
La rovente estate 2019 (in genere la
terza più calda nelle lunghe serie di misura delle Alpi e del
Nord-Ovest italiano) ha fuso non solo tutta l'abbondante neve
stagionale che a fine primavera copriva il ghiacciaio (spessori
tra 305 e 440 cm al sopralluogo del
17 giugno 2019), ma anche cospicui spessori del ghiaccio
sottostante, tra un minimo di 98 cm (palina n. 1, Colle Ciardoney)
e un massimo di circa 270 cm (palina n. 7, settore frontale).
Il bilancio di massa
complessivo è risultato di -1,65 m di acqua equivalente, peggio
della
stagione 2017-18 (-1,45 m) e della già negativa media dei
precedenti 27 anni di osservazione (-1,32 m/anno).
Le due nevicate
del 5-6 e 10 settembre 2019 hanno temporaneamente interrotto
l'ablazione glaciale evitando perdite di massa ancora superiori,
ma durante il sopralluogo, con il rapido aumento di temperatura (Tmax
16 °C alla stazione meteorologica presso la fronte del ghiacciaio),
la fusione già era in via di ripresa, per tornare a livelli estivi
nei giorni successivi (14-17 settembre) su un ghiacciaio di nuovo
completamente spoglio.

Preparativi per il
decollo in elicottero dalla centrale
IREN di
Rosone (Valle Orco)
con la ditta
Airgreen.

Come da previsione,
il cielo è perfettamente sereno e l'atmosfera calma e tiepida, sotto
gli anticicloni "Friederike" e "Gaia" distesi dall'Atlantico, alle
Alpi, all'Europa centro-orientale.
Dopo la breve parentesi fresca e a tratti perturbata della prima
decade di settembre 2019 le temperature sono rapidamente aumentate con
il contributo di aria calda subtropicale in quota: il radiosondaggio
eseguito all'aeroporto di Cuneo-Levaldigi alle h 00 UTC
(le 2 locali, in piena notte) del 13 settembre ha rilevato 0 °C a circa 4600 metri.

Come di consueto la
palina ablatometrica al Colle Ciardoney (n. 1) è la prima ad essere
controllata una volta atterrati sul ghiacciaio: Luca Mercalli, rimossi
i 20 cm di neve recente, indica il segmento di legno che rivela una
perdita di spessore di ghiaccio di 98 cm rispetto al
controllo del 10 settembre 2018.
Almeno metà di questa riduzione è attribuibile in realtà alle fasi
finali della precedente e lunga stagione di ablazione, tra il
sopralluogo del 10 settembre 2018
e la prima nevicata del 1° ottobre 2018.

Il cineoperatore
RAI Guido Borzillo riprende Luca Mercalli e Fulvio Fornengo durante la
misura dell'ablazione alla palina n. 2.
Qui la perdita di spessore in un anno è stata di 157 cm.

Scendendo di quota,
ancora più massiccia è la perdita di spessore alla palina n. 3, nel
settore mediano: -238 cm. Un anno prima la superficie del ghiacciaio
si trovava al livello indicato con il metro flessibile da Fulvio
Fornengo e Luca Mercalli.

Avvicinandosi alla
fronte vengono rintracciati tra la neve fresca in fusione i resti
della palina n. 7, quella più a valle, completamente fuoriuscita dal
ghiaccio evidenziando una perdita di spessore di almeno 265 cm (si
stima circa 270 cm, essendo la palina caduta verosimilmente subito
prima della nevicata che ha interrotto la fusione il 5-6 settembre
2019, presentando tracce fresche di limo glaciale non ancora "lavato"
dalle precipitazioni).
Poiché in questo settore lo spessore del ghiaccio residuo è molto
modesto, forse inferiore a 5-10 m, e al tasso di ablazione attuale
scomparirà in 3-4 anni, questa palina non verrà più rinnovata,
e le misure relative al pendio frontale verranno affidate alla sola
palina
n. 6. Dall'avvio del bilancio di massa nel 1992 sul ghiacciaio
Ciardoney, si tratta del primo punto di misura ad essere perso
per effetto della deglaciazione.
L'entità delle
perdite di spessore glaciale alle singole paline ablatometriche,
rispetto
al 10 settembre 2018, è stata la seguente:
1. (Colle
Ciardoney, circa 3100 m): -98 cm
2. (circa 3050 m): -157 cm
3. (circa 3000 m): -238 cm
4. (circa 3000 m): -123 cm (posizione più ombreggiata,
scomparsa tardiva della neve)
6. (circa 2950 m): -232 cm
7. (circa 2900 m): -270 cm circa
(palina n. 5 non più
presente)
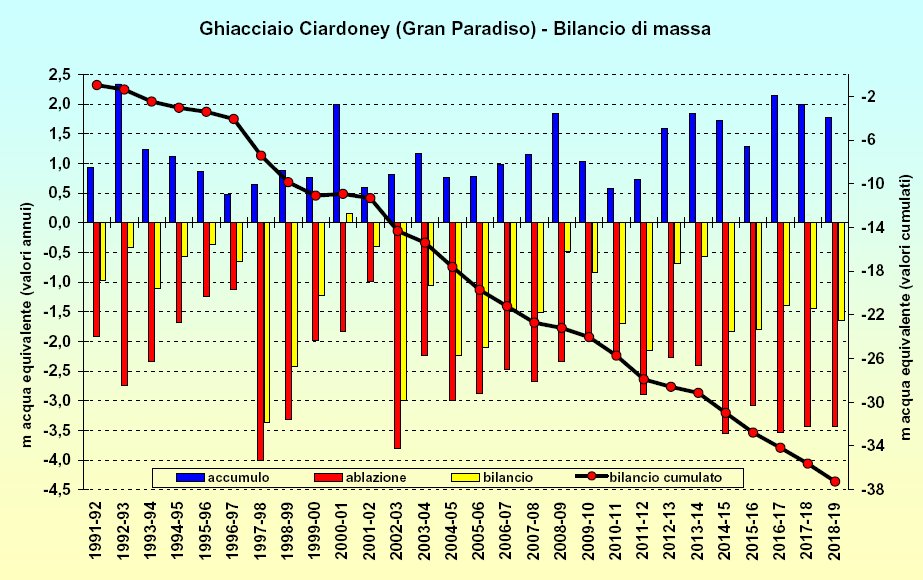
Serie delle misure
di accumulo invernale, ablazione estiva e bilancio di massa netto.
Il valore complessivo di bilancio di -1,65 m di acqua equivalente
della stagione 2018-19
appare più negativo della già sfavorevole media dei 27 anni di osservazione precedenti
(-1,32 m).
Il bilancio cumulato dal 1992 è ormai di -37,3 m
(clicca sul grafico per ingrandire).
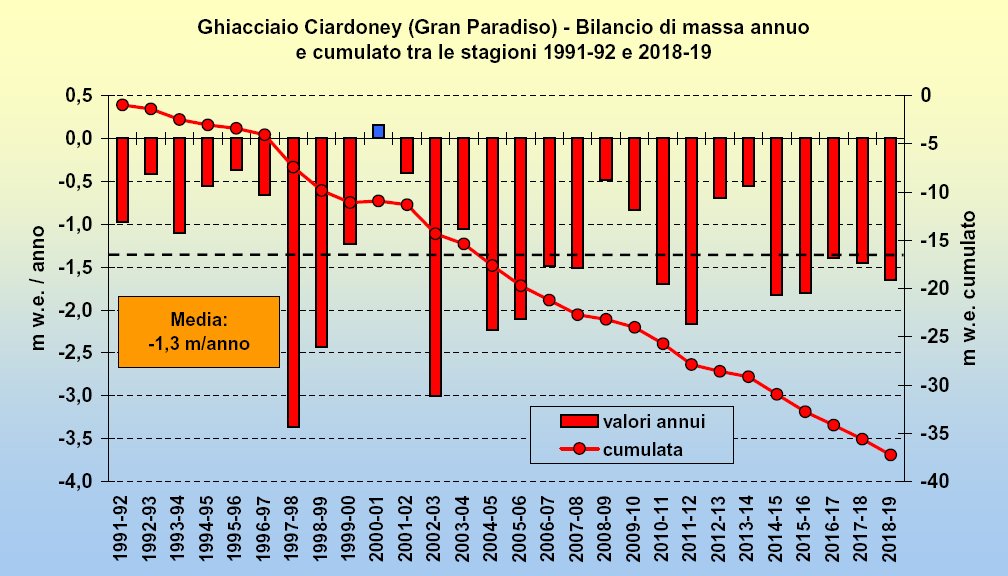
Dettaglio della
serie del bilancio di massa netto (ghiaccio perso ogni anno
nell'insieme del ghiacciaio, espresso come "lama" d'acqua media, in
m).
La media di tutta la serie di misura (28 anni) è pari a -1,33 m/anno,
ma nel tempo si è aggravata, da -1,03 m/anno nel periodo 1992-2002
a -1,53 m/anno nel 2003-2019. Solo nella stagione 2000-01, grazie
a un inverno molto nevoso e a un'estate non troppo calda, si osservò
un bilancio lievemente positivo (+0,16 m)
(clicca sul grafico per ingrandire).
.

Tre "mulini"
glaciali erano presenti nel settore mediano del ghiacciaio, in
corrispondenza del cambio di pendenza poco a monte della palina n. 3.
Alle 10 del mattino del 13 settembre 2019 la fusione era ancora
modesta, ma (al centro dell'immagine) si notavano i segni del
trasporto e rimaneggiamento di neve fresca ad opera del copioso
ruscellamento del giorno precedente lungo le bédières in ingresso nel
pozzo superiore. Segno che nel primo giorno pienamente soleggiato dopo
le nevicate, la fusione era prontamente ripresa.

Abbozzo di "fungo"
o "tavola" glaciale nel pendio frontale del ghiacciaio. Uno dei
numerosi massi precipitati dalla parete Nord della Grande Uja di
Ciardoney ombreggia e protegge dalla fusione il ghiaccio sottostante,
che rimane in rilievo foggiando una sorta di piedistallo
(vedi "glacier table" nel
glossario glaciologico US Geological Survey).

L'intensità della fusione glaciale nell'estate 2019 è evidenziata
anche dalle bèdières formate dal ruscellamento superficiale nel pendio
verso la fronte, profonde talora più di 3 metri, come raramente era
capitato di vedere in oltre un trentennio di monitoraggio del
ghiacciaio.


Luca Mercalli
misura l'arretramento della fronte al segnale "A4E":
8,5 m di ritiro rispetto al 10 settembre 2018.


Dato il rapido
allontanamento (regresso) del margine del ghiacciaio dal segnale di riferimento
per le misure frontali, per maggiore comodità dei prossimi rilievi il
segnale "A4E" è stato rinnovato come "A4F" su un grande e stabile
masso a 21 m dal ghiaccio, mantenendo invariata la direzione di
misura (in alto, Daniele Cat Berro segnalizza con la vernice il nuovo
richiamo del caposaldo; foto L. Mercalli).
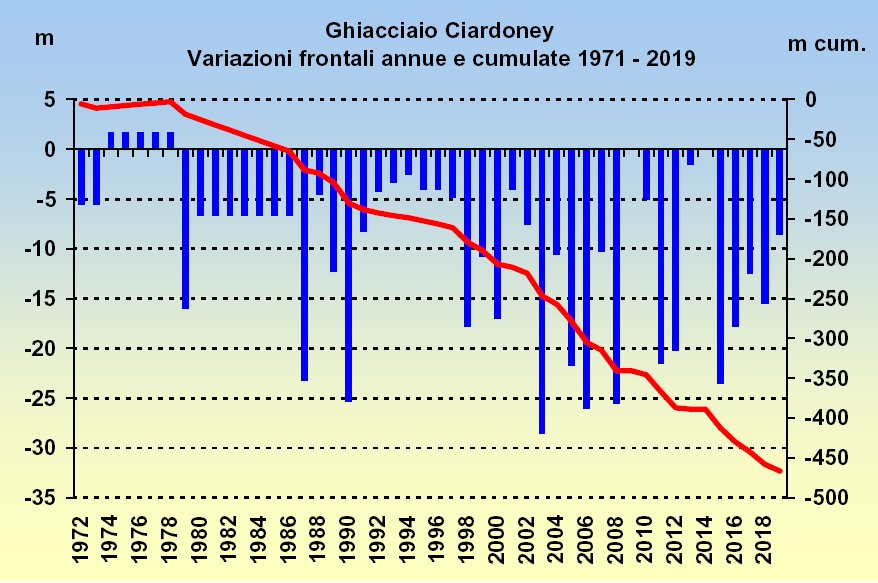
Il regresso annuo
di 8,5 m ha portato a ben 467 m circa il ritiro complessivo
dalle prime misure del 1972 (clicca sul grafico per ingrandire).


Un esemplare di
falena è stato rinvenuto morto nella
neve a circa 2950 m, verosimilmente sospinto dalle brezze termiche
ascendenti nelle ore centrali del giorno (brezze di valle).


Il segnale di
misura A5C, in destra orografica della fronte glaciale, abbandonato
dal 2017: in questo tratto il margine del ghiacciaio, sepolto da
abbondante detrito, non è più identificabile. Il confronto fotografico
mostra la situazione il 22 settembre 2014 e il 13 settembre 2019: è
evidente il marcato smagrimento del pendio frontale in appena 5 anni.


La trasformazione
dell'ambiente locale, in oltre trent'anni di regolari campagne
glaciologiche di fine estate, è stata impressionante, come mostra
anche il
confronto tra le fotografie riprese dalla stazione di riferimento "S2"
il 5 settembre 1986
(data della prima salita di Mercalli e Fornengo, dopo che il
ghiacciaio non veniva più controllato dal 1978) e il 13 settembre
2019.
In questo lasso di tempo la fronte si è ritirata di 400 m e la
superficie glaciale si è abbassata di circa 60 m nel settore
inferiore, che da un profilo convesso (apice di una fase di avanzata,
1986) è passato ad avere un profilo appiattito e perfino leggermente
concavo.
Al perdurare delle
condizioni attuali si ipotizza che nell'arco di un decennio (forse
meno) la fronte glaciale possa portarsi rapidamente all'altezza della
barra rocciosa che sempre più sta affiorando dalla sinistra orografica
verso il centro del ghiacciaio
(al centro dell'immagine recente).

Nei detriti
abbandonati dal ghiacciaio in ritiro le prime isolate piante erbacee
pioniere (generi Artemisia, Silene, Linaria...) spuntano già dopo 2-3
anni, ma data la quota elevata (2850 m), le basse temperature (media
annua prossima a 0 °C) e il substrato minerale a prevalenza di gneiss
occhiadini, di difficile alterazione e dotato di scarsissima sostanza
organica, la colonizzazione vegetale è molto lenta, benché sicuramente
favorita dal riscaldamento atmosferico dei decenni recenti (nella foto
di L. Mercalli, esemplare di Artemisia genipi sul pianoro
detritico di fronte al ghiacciaio).

Nei pressi della stazione meteorologica, laddove il ghiaccio è
scomparso da circa 80 anni, è stato osservato il primo esemplare di
salice nano (f. L. Mercalli).


L'elettricista
Diego Marzo (in alto) e l'ingegnere Mario Berger (qui sopra) durante la manutenzione della
stazione meteorologica "Campbell", sempre in piena
efficienza
(f. L. Mercalli).

Tuttavia le
tempeste di vento e la pressione esercitata dalla massa di neve
invernale sui tiranti di controventatura hanno determinato nuovi danni
al traliccio della stazione meteo, portando alla rottura di uno dei
tre tubolari in alluminio. Alla sgradita sorpresa si è prontamente
rimediato con una "steccatura" in acciaio in vista del nuovo inverno.
Il ripristino della perfetta verticalità del traliccio ha anche
permesso di migliorare il segnale radio per la trasmissione a valle
delle
immagini webcam, saltuario da alcune settimane (lavoro curato
del tecnico elettricista Diego Marzo e dall'ingegnere Mario Berger).
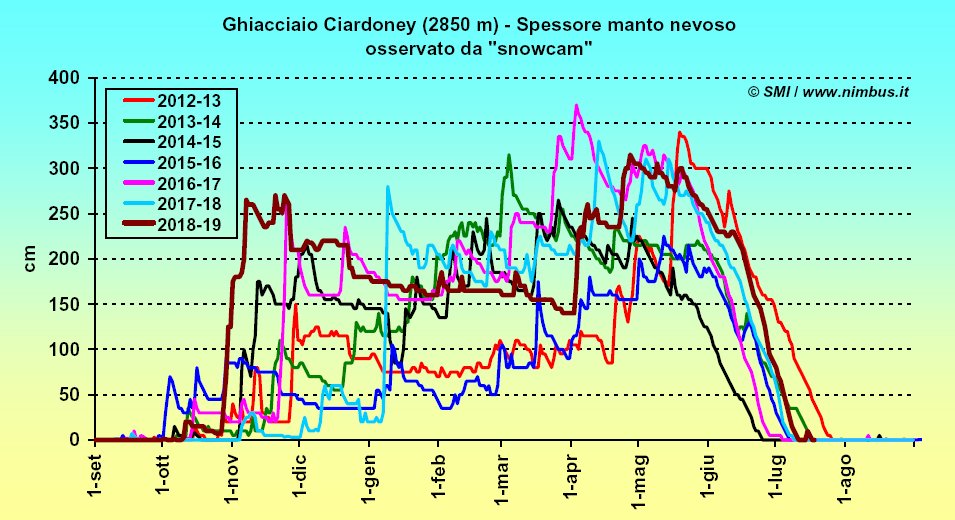
Andamento
giornaliero dello spessore nevoso totale al suolo alla stazione
meteorologica, dall'annata idrologica 2012-13 in poi (osservazioni da
"snowcam").
La fusione nivale osservata nel giugno 2019 (linea marrone) è stata la
più rapida degli ultimi 7 anni, insieme ai casi del 2017 (linea viola)
e 2018 (linea azzurra).
Così, dopo
un'ottima
stagione di alimentazione e il ritardo nell'avvio della fusione
nivale dovuto alla
frescura insolita di maggio, i 200 cm di neve ancora presenti
al sopralluogo del 17 giugno 2019 sono rapidamente fusi in 24 giorni
(-8,3 cm/giorno) a causa del
caldo estremo di fine giugno; il manto nevoso è scomparso del
tutto l'11 luglio alla stazione meteo, e intorno al 25 luglio sono
avvenuti i primi affioramenti di ghiaccio vivo sul pendio inferiore
del ghiacciaio (clicca sul grafico per ingrandire).
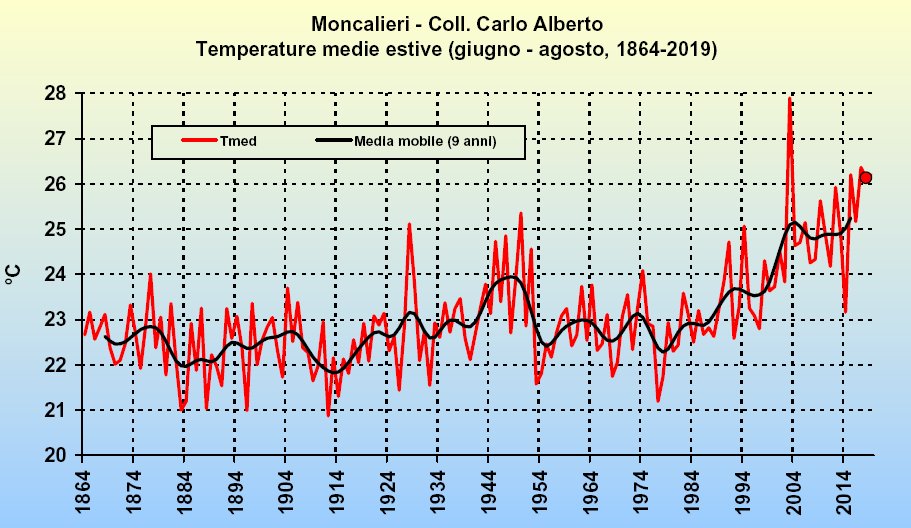
Con 2 °C sopra
media, l'estate 2019
(trimestre giugno-agosto) è stata la terza più calda nelle lunghe
serie di misura del Piemonte e delle Alpi occidentali, come
all'osservatorio SMI di
Moncalieri-Collegio Carlo Alberto, dopo i casi storici del 2003 e
2017, e pari merito con quello del 2015 (clicca sul grafico per
ingrandire).
Al Ghiacciaio Ciardoney le stagioni 2016-17, 2017-18 e 2018-19 hanno mostrato
forti analogie in termini di accumulo nevoso invernale (tra 1,78 e
2,14 m di acqua equivalente), di temperature
estive, e di conseguenza anche di fusione e perdite di massa glaciale
(bilanci compresi tra -1,39 e -1,65 m).
Mentre il gruppo di lavoro SMI conduceva le misure di bilancio di
massa, la ditta
Imageo srl,
specializzata in geologia e geomatica, ha eseguito tre
sorvoli del ghiacciaio tramite drone per ottenerne un rilievo
fotogrammetrico completo (a cura del geologo Walter Alberto e del
topografo Luigi Perotti).
Ciò permetterà l'aggiornamento del dato di superficie del
ghiacciaio e l'elaborazione di un modello dell'apparato
glaciale georeferenziato con precisione centimetrica,
con possibilità di confronto con rilievi precedenti e determinazione
del bilancio di massa geodetico (ovvero a partire dalle
differenze altimetriche dei singoli punti del ghiacciaio, da
confrontare con il bilancio ottenuto con il consueto metodo
glaciologico diretto / paline ablatometriche).
Una preziosa opportunità concessa dalle
attuali tecnologie, inimmaginabile fino a pochi anni fa, e men che mai
quando, nel 1986, venne avviato il monitoraggio continuo di questo
ghiacciaio!
I primi dati del rilievo topografico verranno diffusi a breve con un apposito aggiornamento.

Il geologo Walter
Alberto (a sinistra) e il topografo Luigi Perotti (a destra) di
Imageo Srl
si apprestano a eseguire la ricognizione topografica da drone (f. L.
Mercalli).


Il geologo Walter
Alberto di
Imageo Srl mentre telecontrolla il volo del drone per il rilievo
topografico completo del ghiacciaio.

Il drone "Phantom
4" in volo sopra il pendio inferiore del ghiacciaio.
La presenza di un sottile strato di neve recente non ha penalizzato
l'efficacia del rilievo fotogrammetrico, mettendo anzi più in
evidenza i limiti del ghiacciaio laddove questi, in assenza di
neve fresca, sarebbero stati di più incerta determinazione a causa della
copertura detritica (la neve fresca si era mantenuta solo in presenza di
ghiaccio sottostante, mentre era ormai fusa sulle morene e le
superfici rocciose circostanti).

Dettaglio del drone
"Phantom 4" in volo sopra al ghiacciaio.

Stazione GPS di
riferimento per la georeferenziazione dei punti sulla superficie del
ghiacciaio con precisione dell'ordine dei 3-5 cm.


Ricevitore GPS
durante il rilievo topografico di alcuni punti di riferimento sul
ghiacciaio, segnalizzati tramite apposite mire colorate, ben visibili
nelle riprese fotogrammetriche.

Lo strato di neve
fresca metteva in evidenza anche i piccoli ghiacciai meridionale e
settentrionale di Valsoera, in gran parte nascosti da abbondante
detrito roccioso franato dai versanti (specie il settentrionale, a
destra nella foto).
Immagine ripresa dal Colle Ciardoney.

La modesta placca
del ghiacciaio di Geri, sotto l'ombrosa parete Nord del Monte Gialin
(3270 m), vista dalla stazione meteorologica a valle del ghiacciaio
Ciardoney.
La neve recente di inizio settembre 2019 nasconde la superficie del
ghiacciaio,
forse rimasto coperto fino al termine dell'estate da accumuli di
valanga.

Dalla stazione
meteorologica guardando a Sud-Est, verso la Val Soana e le Prealpi
Canavesane. La forte stabilità atmosferica e l'aria asciutta (umidità
relativa 25-50% tra 2000 e 3500 m) inibiscono lo sviluppo delle nubi
cumuliformi diurne, che assumono un aspetto stratificato intorno ai
2000 m.

Ore 14: appare
l'elicottero per il recupero di personale e materiali. A differenza di
altre campagne di misura, svolte in condizioni più marginali per la
risalita di cumuli diurni, e con volo di rientro a valle risicato
nelle ultime schiarite tra le nebbie, stavolta l'ottima visibilità
concede il tempo adeguato per completare a dovere una complessa
sessione di lavoro (misure di bilancio di massa, riprese televisive,
manutenzione della stazione meteorologica, rilievo topografico con
drone).

Il settore
mediano-superiore del ghiacciaio Ciardoney (in alto, l'omonimo Colle)
ripreso dall'elicottero durante il rientro verso la centrale IREN di
Rosone. Il sottile strato di neve fresca in fusione già lascia
affiorare a tratti il ghiaccio sottostante, più scuro.

Durante il volo di
rientro, uno sguardo a Ovest verso il Gran Paradiso (4061 m, la cresta
sullo sfondo, al centro dell'immagine).
Si notano, a destra, il ghiacciaio pensile della Becca di Gay (3621
m), a fil di cielo, e, poco sotto, il ghiacciaio della Roccia Viva,
nel Vallone di Piantonetto.
Salvo diversa
indicazione, le immagini sono di D. Cat Berro.
Segui in in tempo reale la situazione
sul Ghiacciaio Ciardoney (dati
meteo e webcam)
Devolvi il 5 per mille alla SMI,
sosterrai le ricerche sul Ghiacciaio Ciardoney!

|